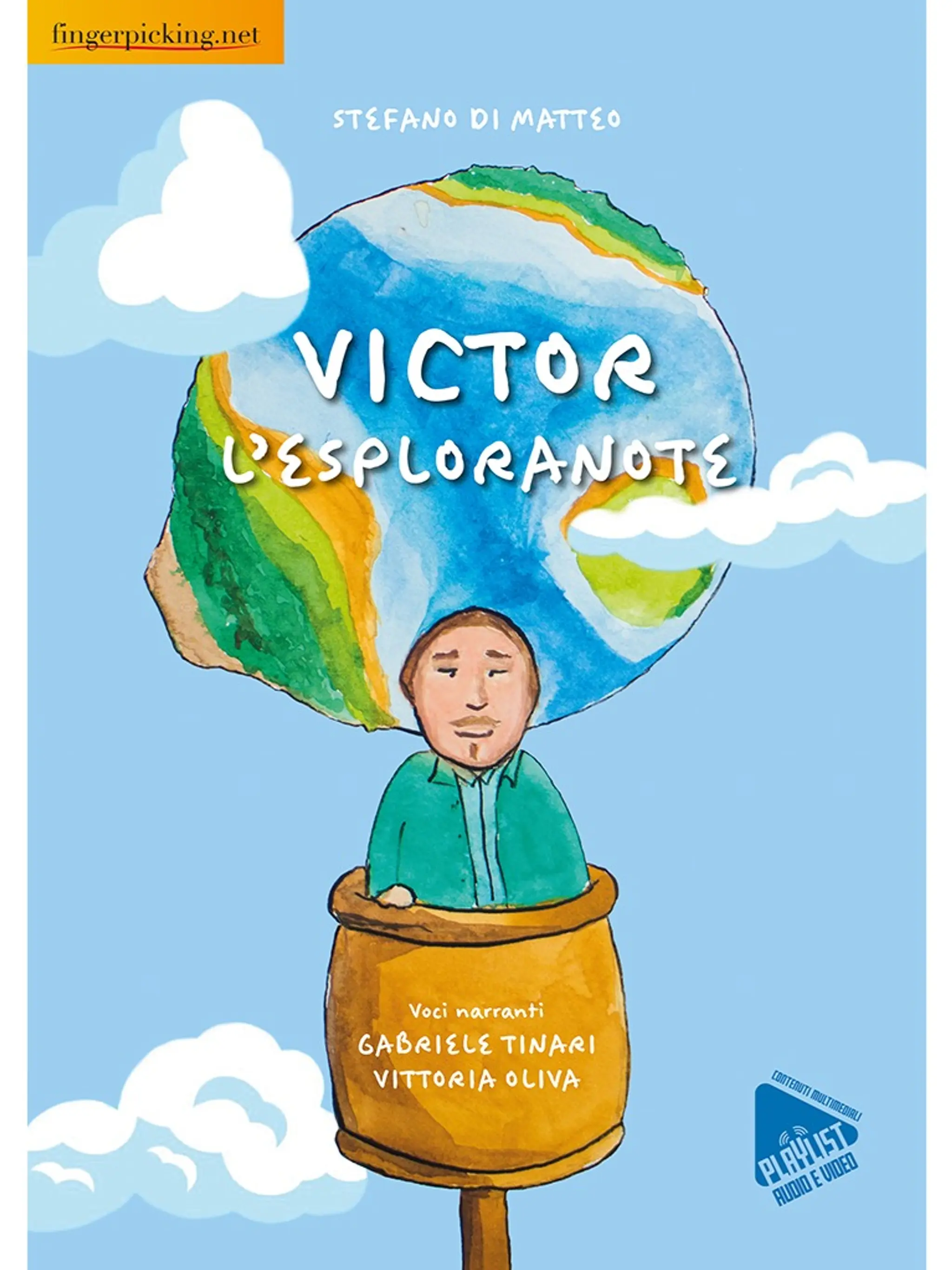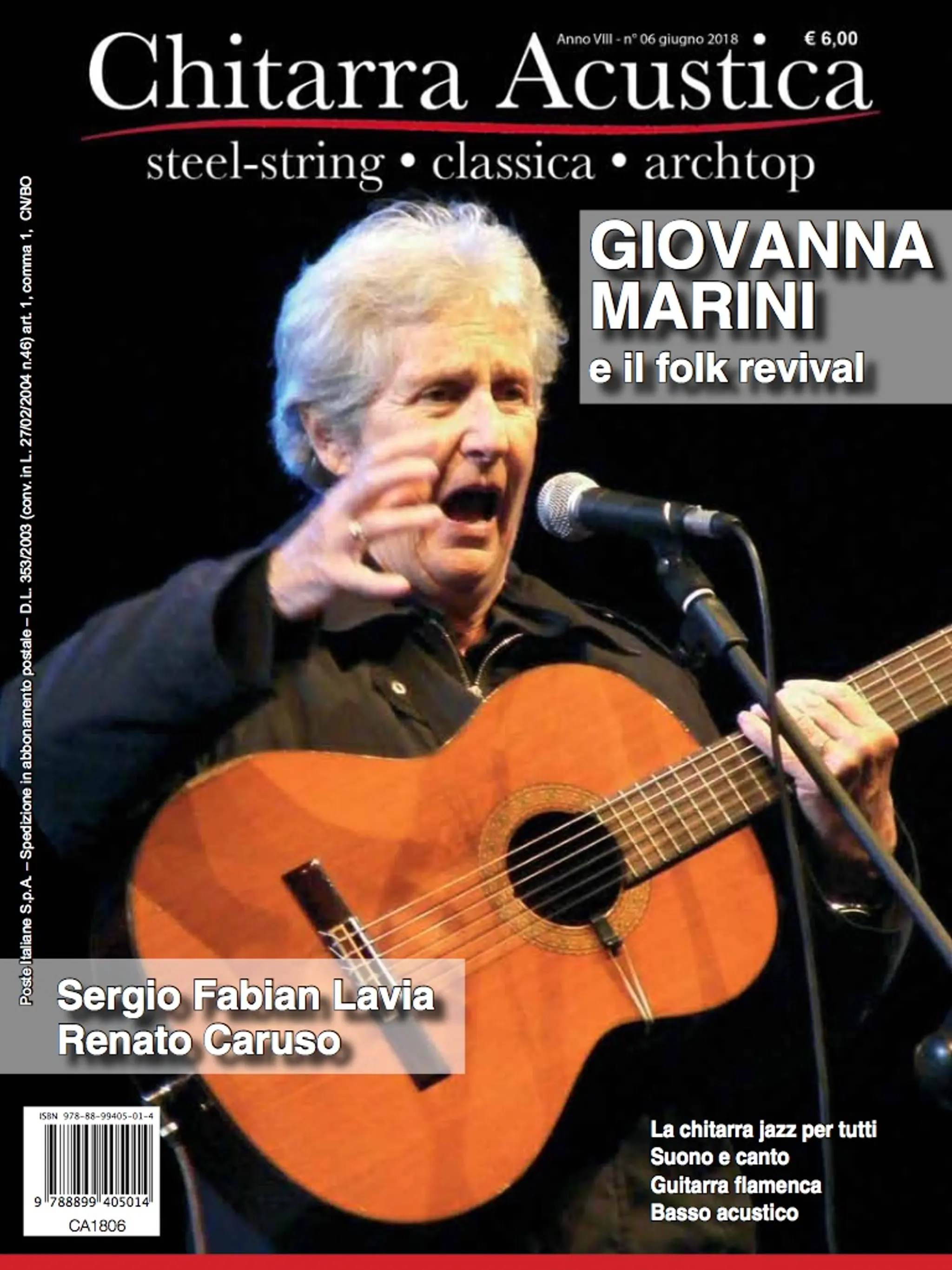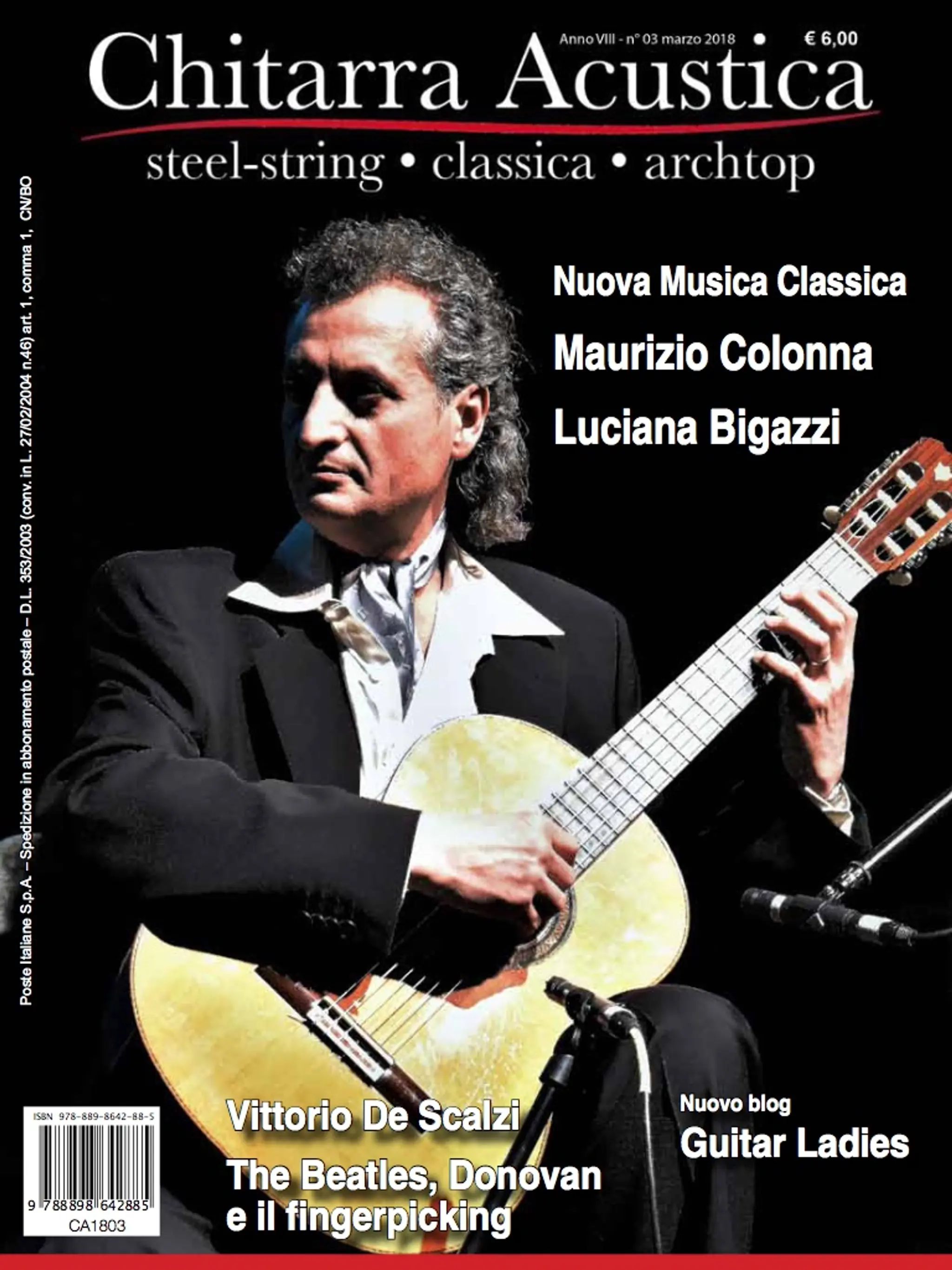Stefano Tavernese & Lino Muoio
Stefano Tavernese & Lino Muoio Il mandolino blues e altre storie di RENO BRANDONI www.renobrandoni.it e ANDREA CARPI andrea.carpi@fingerpicking.net Dovrei andare molto indietro con la memoria per ricordare il mio primo incontro con Stefano Tavernese. Non ne voglio parlare, anche se credo che un tale sforzo risulterebbe gradito a entrambi, non tanto per la valenza artistica dell’incontro, in un’epoca in cui – quando si suonava – i teatri erano pieni; non tanto per l’idea della jam finale (che ora si fa sempre più raramente), visto che io ero quello che apriva il concerto e il gruppo bluegrass in cui suonava Stefano aveva invitato me e Antonio Calogero – all’esordio teatrale del nostro duo – a esibirci con loro; non tanto per… E allora perché, vi chiederete? Soprattutto per il tempo passato e la voglia di entrambi di guardare al futuro mirando ancora a obiettivi ambiziosi e professionali. Però, mi accorgo che nel dire di cosa non ‘voglio’ parlare, con astuzia ne ho parlato, identificando un periodo e una storia che spesso viene dimenticata o travisata. Non che questo abbia particolare importanza, la nostra vanità è scemata da tempo: immaginatevi quindi com’era all’epoca! Ma sarebbe utile parlarne per sottolineare come il passato ci abbia condotti sin qui, perennemente amici, guidati da stima reciproca e rispettosi l’uno dell’altro. Ora devo fare una confessione che Stefano conosce già, ma mi piace renderla pubblica. Ho sempre cercato di allontanarmi dalla ‘chitarra’, intesa come strumento virtuosistico, per avvicinarmi alla ‘musica’. Odio i competitor dalla mano veloce, che sparano note a profusione, in equilibrio su di un piede e con una mano dietro la schiena. Amo chi cerca la nota giusta, il metro e la misura del suono. Stefano è uno di questi: il suo polistrumentismo mi ha sempre affascinato e spesso ho sognato un tour in cui potessi condividere le mie composizioni con la sua arte, utilizzando di volta in volta chitarra, dobro, lap steel, mandolino… e chissà ancora quali altri suoni, che il buon Tavernese tiene nascosti. La sua proposta di parlare del mandolino blues in un libro, quindi, non mi ha sorpreso: raccontava di lui, del suo percorso e della sua vita. Mi ha stupito il fatto che si sviluppasse in compagnia. Infatti il progetto è stato condiviso con un altro abile musicista, Lino Muoio. Non capivo la necessità dell’impiego di due mandolini, ritenendone uno più che sufficiente. Ma quando i due sono arrivati a casa mia e hanno iniziato a registrare i video di supporto al testo, ho subito compreso la portata del progetto e l’importanza della loro ‘unione’ musicale. Non conoscevo Lino, ma è bastato pochissimo per allinearlo, in stima, a Stefano. Credo che la sensazione positiva sia stata reciproca. Infatti, dopo qualche giornata di lavoro in cui, nella pausa pranzo, giunti al caffè, esprimevo il mio desiderio di provare un vero caffè napoletano preparato nella cuccumella (che non possedevo), Lino – ritornato a casa – ha pensato bene di inviarmene una come regalo, indicandomi la miscela Passalacqua come il giusto complemento al suo dono. Ebbene, da allora, non ho mai abbandonato la sua caffettiera e il rito del caffè è diventato per me ancora più magico. Vi sembra un particolare insignificante? Invece io lo reputo un gesto rispettoso. Raro di questi tempi e che solo una persona di grande cuore può compiere. D’altra parte, basta ascoltare la sua musica per capirne lo spessore. Cosa c’entra questo con la musica e con la vita artistica dei due personaggi? Niente! Se non siete dei caffeinomani e volete farvi i fatti loro, leggete pure l’intervista realizzata da Andrea e non dimenticate di prendere il loro libro che parla del mandolino blues. Anche se siete chitarristi, non potrete non rimanere affascinati da questo strumento. È sufficiente guardare un solo video per rimanere conquistati e desiderare subito di diventare mandolin addicted. (r.b.) L’intervista Come sono stati i vostri inizi con la musica? E con il mandolino? Stefano: La colpa è del supplente di musica in seconda media. Era giovane e con idee molto più moderne del professore titolare. Scoperto che abitava dietro casa, andai da lui per delle lezioni di chitarra con un compagno di classe e lui mi fece conoscere il magico mondo della musica tradizionale americana e inglese, Joan Baez, i Traffic… Il mandolino l’avevo in casa, di mio padre, ma furono i dischi di country rock di un amico a farmi scoprire che poteva essere più versatile di quanto potessi immaginare. Da lì al bluegrass il passo è stato veloce. Lino: Ho sempre ascoltato la musica, sin da piccolo. Poi sono venuti gli anni dell’heavy metal con i chitarristi ‘fighi’ e capelloni. Non ero né figo né capellone, quindi mi è rimasta la chitarra… Al mandolino invece ci sono arrivato molto dopo, quando, durante la collaborazione con i Blue Stuff, abbiamo deciso di introdurre uno strumento che collegasse Napoli e il blues. Così… mentre ascoltavo Charlie McCoy… è scoppiata la scintilla. Stefano Stefano, il 1982 è stato per te un anno decisivo, che ha visto la pubblicazione dell’album Beyond Bluegrass degli Old Banjo Brothers e la loro presenza nell’antologia I Convention italiana di musica Old-Time & Bluegrass, punti di approdo della tua attività nel nascente movimento italiano ispirato alla musica country e bluegrass. Puoi raccontarci di quegli anni, in buona parte vissuti nel leggendario Folkstudio di Roma? Non ero ancora maggiorenne quando mi ritrovai a suonare al Folkstudio, dove il boss Giancarlo Cesaroni prese in simpatia la nostra band, i Country Report. Per ragazzi come noi, autodidatti e intraprendenti, l’aria era molto stimolante e – alla metà degli anni ’70 – a Roma si moltiplicavano i locali in cui proporre la nostra musica. Ho ricordi molto belli, fatti anche di incontri con tanti musicisti di ogni livello, mentre approfondivo la conoscenza degli strumenti. Qualche anno dopo sono nati gli Old Banjo Brothers e, con compagni di viaggio preziosi come Leonardo Petrucci e Mariano De Simone, ho avuto la fortuna di partecipare alle prime convention italiane dedicate a old-time e bluegrass, realizzando anche l’album della nostra band, praticamente il primo del genere in Italia. Nel 1982 è anche uscito per la casa editrice Anthropos il tuo pionieristico Il manuale degli strumenti country, nel quale affronti le tecniche di chitarra, banjo, fiddle e mandolino. È interessante che, in questa tua definizione come multistrumentista, riprendi una consuetudine abbastanza diffusa nella comunità dei musicisti country-bluegrass, che spesso suonano più di uno degli strumenti caratteristici del genere. È da sempre un vantaggio e un limite per me quello di aver distribuito il mio impegno su vari strumenti a corda. Con i Banjo Brothers ero la voce solista e suonavo violino e mandolino, ma parallelamente avevo fatto amicizia anche con la chitarra e il banjo a 5 corde. Tornato da un fruttuoso soggiorno di qualche mese negli Stati Uniti, agli inizi degli anni ’80 si presentò anche l’occasione di scrivere questo manualetto in cui cercavo di dare qualche elemento essenziale per conoscere i quattro strumenti nel quadro della musica country americana. Era decisamente ‘basico’ ma forse a qualcuno è stato utile. A partire da questo manuale, e parallelamente alla tua attività musicale, si è sviluppata un’intensa attività editoriale e giornalistica, che ha preso una parte importante della tua vita: dalla collaborazione come trascrittore musicale per “I Quaderni di Chitarra” di Anthropos ai diversi ruoli ricoperti in Guitar Club, Chitarre e oggi Musicoff. Come hai costruito e conciliato questi due aspetti della tua figura professionale? Be’, qui la colpa è di un certo Andrea Carpi, che mi ha tirato dentro a un’ulteriore avventura che è poi proseguita per una trentina d’anni tra vicende varie! Nel frattempo ho continuato a suonare, ma il rapporto fra le due cose non è stato sempre facile. Ci sono stati momenti in cui nell’ambiente giornalistico guardavano con sospetto il mio essere musicista e, viceversa, mi trascino ancora oggi la sensazione che qualcuno mi prenda meno sul serio nella professione musicale a causa del mio lungo percorso all’interno della stampa. In termini pratici, i due aspetti si sono nutriti a vicenda. Ad esempio, aver conosciuto e intervistato dozzine di grandi chitarristi mi ha decisamente arricchito anche come musicista. I tuoi libri, poi, hanno consolidato la tua natura eclettica e la tua mentalità aperta ai diversi generi musicali, a tratti enciclopedica: nel 2001, Steve Vai – Chitarra aliena dal pianeta terra, con Mauro Salvatori e la collaborazione di Stefano Micarelli e Simone Sello; nel 2003, la Grande enciclopedia della chitarra e dei chitarristi; nel 2006, Jimi Hendrix – Angeli e chitarre, con la collaborazione di Daniele Bazzani; nel 2017, La storia della chitarra rock con Luca Masperone. Ho cercato sempre di non pormi limiti inutili e di dedicare attenzione e interesse anche ad artisti abbastanza lontani dalla mia diretta esperienza musicale. Il lavoro enciclopedico è stato quello più impegnativo e allo stesso tempo appassionante, un viaggio sempre più approfondito all’interno di un mondo straordinario come quello della chitarra, strumento semplice e complesso per eccellenza. Tornando alla musica suonata, dopo l’esperienza con gli Old Banjo Brothers hai avviato un’attività solistica nel 1985 con la partecipazione all’antologia Old-Time & Bluegrass In Italia, con il tuo Harvest Moon e forse, in seguito, qualche tentativo cantautorale. Quali sono state le novità in questa tua nuova dimensione? Essendo per certi versi più cantante che strumentista puro, e avendo iniziato presto a scrivere canzoni, il salto era scontato. All’inizio, negli album che citavi, ho raccolto le varie esperienze fatte nella musica nordamericana – dal repertorio tradizionale al country-bluegrass, al blues e allo swing delle origini – cantando in inglese. Poi ho fatto un passo impegnativo, quello di scrivere canzoni in italiano, e ho anche registrato un intero album alla fine degli anni ’80, andando vicino a vederlo pubblicato; ma poi… non è andata. E magari è meglio così. Nel tuo approccio al bluegrass era presente il riferimento ‘progressivo’ al cosiddetto newgrass, con la sua miscela di bluegrass e swing. In questa direzione è stata importante la tua partecipazione al gruppo Les Hot Swing, tra musica manouche e swing italiano, con l’album omonimo del 1989 e Swingarsela del 2004. Con Les Hot Swing ho vissuto la storia più lunga e gustosa, una ventina d’anni di musica e tante risate lungo il percorso. Ho cantato e suonato violino e mandolino in una formazione che si rifaceva a quelle storiche di Django Reinhardt, con un repertorio diviso fra standard, pezzi originali e alcune divertenti canzoni di swing italiano dagli anni ’40-’50. Con Alessandro Russo, estroso e originale chitarrista romano, avevo un’intesa particolare e, con il nostro quartetto, abbiamo passato bellissimi momenti. Tra le tue collaborazioni dell’epoca spiccano quelle con i Gang e la PFM, quest’ultima documentata nell’album www.pfmpfm.it (il Best) del 1998. L’incontro con i fratelli Severini dei Gang è avvenuto nei primi anni ’90, quando erano nel pieno del loro periodo di folk-rock scritto e cantato in italiano. Gran bella avventura in due anni di concerti con una band allargata, in cui suonavo chitarra acustica, elettrica, mandolino, violino, banjo, bouzouki, una quantità infinita di corde! La PFM, pochi anni dopo, è stata una vera scommessa, sempre con chitarre, mandolino e violino. Con la mia tecnica limitata, confrontarmi con la loro musica era una sfida che mi ha portato su una serie di palchi importanti al fianco di musicisti storici e di grande valore, che proprio allora ritornavano a esibirsi dopo una lunga pausa. Tanta emozione e un’esperienza inestimabile. Poi c’è la chitarra slide con il Doppio Dobro Star in duo con Marco Manusso, con cui hai partecipato all’Acoustic Guitar Meeting di Sarzana nel 1999. E infine River Blonde, con l’album The Heart, the Healer & the Holy Groove in duo con Armando Serafini. Diciamo che l’amore per la chitarra slide è cresciuto gradualmente negli anni. Dopo quel primo esperimento assieme a Marco, con cui avevo suonato nell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore, è passato diverso tempo prima di capire che dedicarmi sempre più alle sei corde e al bottleneck era come chiudere il cerchio che mi legava fin dagli inizi al blues. Una decina di anni fa, poi, l’incontro con Adriano Viterbini è stato la molla finale, grazie alla comune passione per Ry Cooder e la sua musica, da cui la collaborazione con i suoi Bud Spencer Blues Explosion e la nascita del duo River Blonde con Armando Serafini, chitarrista votato alle percussioni e al suo famigerato ‘nocche’n’roll’. Continuiamo tuttora a portare in giro il nostro progetto, in cui suono chitarra elettrica, resofonica e bouzouki, tra rielaborazioni e pezzi originali. Negli ultimi tempi hai anche ripreso in mano l’attività didattica con i corsi per il Laboratorio Musicale Varini: Fingerpicking Base del 2017 e Fingerpicking Advanced del 2019. In realtà l’attività didattica non l’ho mai affrontata veramente, salvo casi piuttosto rari. L’offerta di Massimo Varini, vecchia conoscenza fin dai suoi esordi, è stata l’occasione di superare un blocco iniziale e strutturare un corso di base a cui ha fatto poi seguito il secondo. Con mio grande piacere, le lezioni online in video, corredate da spartiti su pentagramma e intavolatura, sono state utilizzate e apprezzate da un bel numero di studenti. Chi l’avrebbe mai detto? Lino Lino, dopo i primi amori per la chitarra elettrica, nel 1999 avvii una lunga collaborazione con lo storico gruppo dei Blue Stuff, suonando nel tempo chitarra e mandolino. Che importanza ha avuto questa esperienza? Be’, direi fondamentale. Con i Blue Stuff abbiamo lavorato sia sull’uso del dialetto napoletano nei testi, come elemento sostanziale del messaggio musicale, sia sul suono del mandolino come elemento rievocativo della tradizione napoletana. Tutto questo è confluito poi nell’esperienza di Mandolin Blues. Dal 2005, oltre al mandolino, hai approfondito la conoscenza di altri strumenti a corda della tradizione americana, come la lap steel, l’ukulele e il banjo. In realtà tutti gli strumenti a corda mi affascinano. Ultimamente sto giocando con una balalaika che i miei comprarono in Russia tantissimi anni fa… Da queste esperienze, nel 2008 scaturisce il tuo primo album solista, Blues on Me. Come è andata sviluppandosi la tua dimensione musicale personale? Studio e lavoro ogni giorno per migliorare come musicista. In tutti questi anni, gli strumenti che mi accompagnano – chitarra, mandolino, banjo, ukulele – sono sempre di più il mezzo e non il fine della mia ricerca musicale. Ed io sono sempre di più focalizzato sulla ricerca del suono anche del singolo strumento, rispetto allo sviluppo delle varie tecniche esecutive. Poi dal 2012 lanci proprio la già citata espressione Mandolin Blues con l’album omonimo, seguìto da una serie di album che fanno capo alla stessa denominazione: nel 2016 con The Piano Sessions, che propongono un dialogo tra il mandolino blues e il pianoforte di Mario Donatone; nel 2017 con Acoustic Party, che vede la partecipazione di Adriano Viterbini, Francesco Piu, Max De Bernardi, Veronica Sbergia, Paolo Bonfanti; per finire nel 2021 con Vedi Napoli… poi Muoio!, in cui ti esprimi attraverso brani originali cantati in dialetto partenopeo. Puoi raccontarci questo percorso? È un percorso di cui sono molto fiero. Con il primo disco omonimo ho iniziato con lo studio e il recupero del ruolo del mandolino nel blues nella storia, scrivendo dei brani in inglese che ne potessero evidenziare le potenzialità espressive. Con The Piano Sessions invece ho sperimentato la dimensione acustica con pianoforte e contrabbasso, con atmosfere più vicine al jazz, mentre in Acoustic Party ho ‘festeggiato’ con tutti gli amici musicisti di blues italiani, concentrandomi sulla dimensione acustica dello strumento. In particolare, per questo disco, mi piace sempre segnalare che gli ospiti non hanno semplicemente partecipato alle registrazioni, ma abbiamo scritto assieme i pezzi, dando così una dimensione completamente diversa al progetto. Infine, con Vedi Napoli ho chiuso un cerchio: sono tornato alla lingua madre, in cui è più ‘naturale’ per me esprimermi, e ho recuperato quell’ironia dei testi, tipica dei Blue Stuff, cercando di intersecare ulteriormente la tradizione blues con quella napoletana, sempre attraverso il mandolino. Inoltre, nel 2017 inizi una collaborazione con Corey Harris: com’è avvenuto l’incontro? Ci siamo incontrati in una serie di concerti, tramite un’agenzia con cui collaboravamo entrambi. A Corey è piaciuto subito il mio approccio e lo stile al mandolino, e da lì sono nate una serie di collaborazioni che tuttora procedono. Cos’è il Mandolin Blues Quartet? È il gruppo con cui vado in giro per i live e che spero di poter tornare presto a proporre È una formazione a cui sono particolarmente legato, perché siamo in quattro e cantiamo tutti dei brani da solisti, oltre a fare un gran lavoro con i cori. Con me ci sono Mario Donatone al piano, Francesco Miele al contrabbasso e Roberto Ferrante alla batteria. Mi diverto davvero tantissimo quando suono con loro. Il mandolino blues E arriviamo al vostro libro Il mandolino blues: com’è nata l’idea e come si è formata la vostra collaborazione? S.: Tutto è partito da un’altra antica amicizia, quella con Reno Brandoni, che da bravo editore mi chiedeva da tempo di proporre qualcosa per la collana didattica di Fingerpicking.net. La cosa che mi è sembrata più stimolante è stata di condensare la lunga esperienza fatta con il mandolino, con particolare riferimento al linguaggio del blues. E qui l’amicizia con Lino Muoio, con cui avevo già collaborato in varie occasioni, ha fatto il resto. Come avete impostato storicamente la vostra ricerca? In questa ottica ci sembra efficace l’intervento di Carlo Aonzo nella prefazione, quando inquadra così il vostro lavoro: «Un mandolino di ritorno che dal Nord America riapproda in patria pregno di nuova cultura, sonorità e tecniche che ne ampliano le possibilità». L.: Sì, infatti, Carlo ha colto esattamente il senso di questo lavoro. L’idea di base è quella di partire dal mandolino blues, inteso come approccio stilistico e interpretativo, e cercare di estendere questo approccio ai vari generi della musica americana fino a tornare indietro alle origini mediterranee. Come avete concepito la parte strettamente tecnica? L.: È un’impostazione direi abbastanza tipica o consolidata nella didattica, almeno in quella statunitense. Si danno agli studenti le basi del linguaggio – scale, accordi ecc. – per poi affrontare la componente interpretativa dei singoli stili musicali. Impressionante la quantità di stili particolari che avete affrontato: old-time, country, slide-bottleneck, bluegrass, fingerpicking, boogie, Chicago blues, rock, funk, jazz, musica mediterranea… Come avete costruito i numerosi esempi stilistici che formano il cuore di questo manuale? S.: Tutto si è sviluppato gradualmente quando abbiamo deciso di non limitarci al mandolino blues storico, ma di mettere lo strumento a confronto con il blues in tutte o quasi le sue derivazioni. A quel punto si è trattato di buttar giù degli spunti che rendessero l’idea del singolo stile, cercando di essere il più coerenti possibile con gli elementi che lo caratterizzano. Gli esempi più insoliti per il mandolino sono quelli per il fingerpicking e per lo slide in accordatura aperta. E come avete concepito le trascrizioni musicali degli esempi stilistici riportati nel libro, veri e propri brani da suonare, in rapporto alle versioni estese delle vostre interpretazioni in video? S.: Per alcuni brani più brevi, è stato possibile mettere la trascrizione completa, mentre per diversi altriabbiamo evitato di dilungarci troppo sullo spartito, lasciando la possibilità di ascoltare e vedere il resto nel filmato. Gli elementi stilistici essenziali sono comunque presenti in tutte le trascrizioni, in riferimento anche alla parte iniziale del libro, dove entriamo nel contesto della tecnica, del fraseggio, degli accordi più importanti nel linguaggio del blues sul mandolino. Come avete registrato i video, che sono di ottima qualità, ripresi con tre telecamere? S.: Grazie alla professionalità sviluppata da Reno Brandoni e al suo accogliente studio, in un paio di giorni abbiamo realizzato i filmati senza troppa fatica, sfruttando il nostro nutrito parco strumenti. In precedenza, a Roma, avevamo realizzato le basi assieme a due amici musicisti, Francesco Miele al basso e contrabbasso e Roberto Ferrante alla batteria e percussioni. Particolarmente innovativa è l’idea dei brani ispirati alle musiche tradizionali del Sud Italia e del Nord Africa. Potete approfondire questa idea? S.: Mentre elaboravamo la struttura del libro è venuto spontaneo metterci al posto del potenziale lettore. Ragionando sui percorsi e ricorsi del blues, l’idea di integrare con una parte dedicata a ritrovarne le tracce all’interno di linguaggi musicali caratteristici del Nord Africa e del nostro Sud è sembrata subito il tassello mancante. Arrivando da due musicisti italiani, speriamo che sia un valore aggiunto anche per il pubblico internazionale cui sarà proposta la versione in inglese. Cosa si intende con l’espressione maqam napoletano? L.: Il maqam arabo, in estrema sintesi, è un sistema di scale, frasi melodiche, abbellimenti e convenzioni estetiche che formano una struttura melodica e artistica tipica della musica mediorientale e mediterranea in genere. I melismi e i microtoni, così centrali nelle tonalità lamentevoli della voce napoletana, hanno un debito verso le scale musicali arabe più che verso i parametri strutturati dell’armonia europea. Interessante anche l’idea di una discendenza che va dall’oud arabo al liuto europeo e alla famiglia del mandolino. L.: Diciamo che in questo senso ci siamo rifatti alla letteratura prevalente sull’argomento. Sebbene ci siano svariate sfumature e ricostruzioni storiche, questa idea di base ci ha aiutato a sviluppare il percorso didattico del libro. In conclusione, come pensate di promuovere Il mandolino blues? E quali sono i vostri prossimi progetti? S.: Stiamo preparando una prima serata di presentazione e in ballo ci sono eventi di rilievo dedicati al mandolino. Le possibilità sono tante e speriamo di portare in giro i nostri strumenti e le nostre storie davanti a ogni tipo di pubblico. L'articolo Stefano Tavernese & Lino Muoio proviene da Fingerpicking.net.
11 December 2023